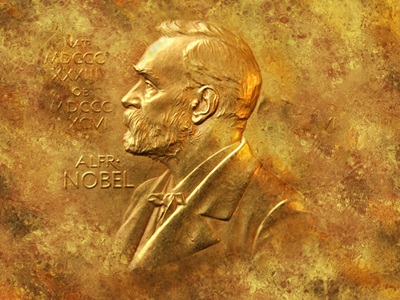Il premio Nobel per l'economia, ufficialmente premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel, l'inventore della dinamite, viene assegnato dal 1969, in seguito all'istituzione da parte della Sveriges Riksbank. Questo premio non era previsto dal testamento di Nobel, ma viene gestito dalla Fondazione Nobel e consegnato con gli altri premi.
Lo scorso anno il Nobel per l’economia ha premiato gli studi di William Nordhaus e Paul Romer, incentrati sullo sviluppo di forme di crescita economica globale sostenibili e, al contempo, capaci di aumentare il benessere della popolazione mondiale. L’assegnazione di quest’anno, in un certo senso, è avvenuta in continuità con quella dello scorso. Gli studi dei tre premiati, Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer, sono incentrati sulla lotta alla povertà e sull’aumento del benessere per le fasce più disagiate della popolazione mondiale.
Combattere la povertà con azioni mirate
Per Banerjee, Duflo e Kremer è più efficace affrontare un problema di grandi dimensioni, come la lotta alla povertà, suddividendolo in tanti “micro problemi” da affrontare utilizzando delle misure correttive. Quali tra queste misure funzionano davvero, e quali, invece, non producono alcun risultato apprezzabile? A questa domanda i tre premi Nobel hanno cercato di rispondere attraverso i loro studi, fornendo risposte supportate da risultati oggettivi e da evidenze scientifiche e numeriche. Essi sostengono che il fallimento di decenni e decenni di misure contro la povertà si possa spiegare con il prevalere di ignoranza, ideologie e inerzia, rispetto all’utilizzo di un metodo di analisi rigorosa e precisa.
Un metodo sperimentale per la lotta contro la povertà
La novità, quindi, rispetto agli studi precedenti, sta nell’applicazione di un metodo scientifico sperimentale, mutuato da quello applicato in medicina. Quest’ultimo consiste nel suddividere il campione su cui viene sperimentata una misura che si pensa possa essere efficace nel contrastare la povertà in due gruppi, i cui membri, scelti con caratteristiche omogenee, sono distribuiti in modo assolutamente casuale, eliminando ogni pregiudizio nella selezione. Solo uno dei due beneficerà del programma che si vuole testare, per esempio, si scelgono 30 bambini che frequentano la stessa classe dello stesso istituto, 15 dei quali assisteranno a lezioni supplementari di matematica e 15 no. L’obiettivo? Dimostrare in modo scientifico e supportando le conclusioni con evidenze numeriche, se le lezioni supplementari hanno migliorato, per esempio, il rendimento scolastico di chi ha assistito alle lezioni e hanno ridotto l’abbandono scolastico. Le ricerche e gli esperimenti, in particolare quelle di Banerjee e Duflo sono avvenute per lo più sul campo, in alcuni Paesi in via di sviluppo. Anche questo approccio più “pratico” e meno accademico costituisce una novità rispetto alle tradizionali metodologie di analisi.
Esther Duflo si è concentrata anche sullo studio delle disuguaglianze di genere. Nei suoi studi ha dimostrato come una maggior rilevanza delle donne nelle scelte politiche ed economiche comporti una differente allocazione della spesa pubblica. Per esempio, le donne sono più propense a destinare risorse economiche per avere disponibile un maggior quantitativo di acqua potabile, invece che per costruire più strade. Gli studi delle Duflo hanno mostrato che lo sviluppo economico certamente può aiutare a ridurre la disuguaglianza tra i generi, ma lo sviluppo economico, da solo, tuttavia, non è sufficiente a produrre uguaglianza completa.
L’importanza dell’istruzione per ridurre la povertà
Le ricerche dei premi Nobel hanno affrontato – e in alcuni casi demolito – l’efficacia di alcuni dei sistemi più usati per ridurre la povertà.
Tra questi c’è senza dubbio la promozione del microcredito che, numeri alla mano, non è poi così efficace nel contrastare e ridurre la povertà. Può, ma solo in alcuni casi, migliorare le condizioni di chi riceve un aiuto economico per avviare un’attività, ma il vero problema risiede nella mancanza di competenze gestionali degli aspiranti imprenditori, e non solo di capitali per avviare l’attività. Anche le istituzioni locali hanno il loro peso: l’efficacia e la bontà dei loro provvedimenti sono in grado di produrre effetti positivi sul territorio che amministrano anche quando il governo centrale è deficitario. Gli studi di Kremer, in particolare, si sono concentrati sulle motivazioni che fanno sì che i Paesi ricchi producano beni più sofisticati, le loro imprese siano più grandi e i lavoratori più produttivi. La spiegazione è stata individuata nelle differenti modalità di organizzazione del lavoro che, nei Paesi sviluppati, fanno lavorare insieme persone che hanno livelli simili di competenze. Il tema dell’istruzione e degli indubbi vantaggi derivanti da un aumento dell’istruzione nella popolazione – in particolare nel miglioramento delle condizioni di vita delle donne e dei bambini - è un altro importante tema sul quale si è soffermata in particolare la ricerca di Esther Duflo.
Che lezione per l’Italia dall’insegnamento dei Nobel?
Anche in Italia, nel corso del tempo, sono state varate molte misure per contrastare la povertà e per favorire l’inclusione sociale. Gli studi condotti dai tre Nobel mettono l’accento sulla necessità di studi che misurino, in modo scientifico e rigoroso, l’efficacia di questi provvedimenti, non solo a posteriori, ma anche a priori e che mettano a disposizione di tutti i risultati di queste analisi.
La carta d’identità dei Nobel 2019
Abhijit Banerjee (nato a Calcutta nel 1961) è attualmente professore di economia della Ford Foundation International presso il Massachusetts Institute of Technology dopo aver insegnato all'Università di Harvard e all'Università di Princeton.
Esther Duflo (nata a Parigi nel 1972) è membro associato della ricerca NBER, membro del consiglio di amministrazione dell'Ufficio di ricerca e analisi economica dello sviluppo (BREAD) e direttore del programma di economia dello sviluppo del Center for Economic and Policy Research. È la persona più giovane e la seconda donna a vincere il premio.
Michael Kremer (1964) insegna ad Harvard economia dei Paesi in via di sviluppo. La teoria più famosa formulata da Kremer è chiamata “O-ring” presentata nel 1993.